Non è un libro facile questo di Luca Ferrieri, fra l’ultimo libro letto e il primo nuovo da aprire. Letture e passioni che abitiamo, Olschiki Editore.
Indica fatica in chi lo ha scritto – credo io – e la fatica la fa sentire a chi lo legge. Perché è un libro che analizza e pratica la lettura senza compiacimenti o tentazioni di missione, e scava a fondo e in ampiezza. È un libro bellissimo.
È un libro per lettori, sulla lettura. Lettori che devono e vogliono fare i conti – con grande attenzione e senza indulgenze – con il concetto di passione associato alla lettura.
Passione? Quale passione?
Luca Ferrieri – che ci vantiamo di avere anche fra gli autori di questo blog – da tanti anni studia e sperimenta la lettura e osserva i lettori, e non ci permette di stare tranquilli ad ammirare narcisisticamente il lettore che ciascuno di noi pensa di essere.
Passione. Non la passione come «grimaldello inoffensivo che si applica a ogni cosa». Quindi non aspettatevi nessuna molla «proselitistica» o «moralistica», nessuna intenzione di «avvicinare i discenti o i discepoli o gli agnelli sacrificali alla lettura»; non c’è tentativo «di presentarla, di celebrarla, di esercitare quella “forza di trascinamento” che si ritiene tipica delle passioni». Non si occupa, Ferrieri, di quei «discorsi sulla passione» che rischiano di «emanare il tanfo dei convertiti, dei catechisti e dei catecumeni, di tutti coloro che pensano che il loro (amore, libro, figlio) sia sempre l’unico o il migliore di tutti.»
Ferrieri si occupa invece
[della] capacità delle passioni, gioiose e tristi, di muovere e disegnare delle letture, caratterizzandone in modo diverso le scelte, le posizioni e il posizionamento; [del]l’articolazione che il gioco delle diverse passioni determina all’interno delle stesse letture, o delle letture dello stesso libro; [del]le conseguenze dell’applicazione delle passioni alla lettura (ad esempio l’amore della lettura, la paura della lettura); [del]l’affinità di passione e lettura.
Ecco allora che il libro si snoda e si articola lungo queste interazioni fra le passioni e le letture. E lo fa con una struttura che si muove su due strade, parallele ma differenti. Una è quella della teoria, l’altra invece «raccoglie frammenti di esperienze e di sguardi leggenti e li annota a margine, in un basso continuo e autobiografico che punteggia il testo principale».
E queste due strade (o due libri in uno) sono ben visibili anche nel modo in cui il testo è organizzato sulla pagina: un corpo centrale e, appunto, una colonna laterale, a margine. Si possono leggere insieme, ma anche stando solo su una delle due strade.
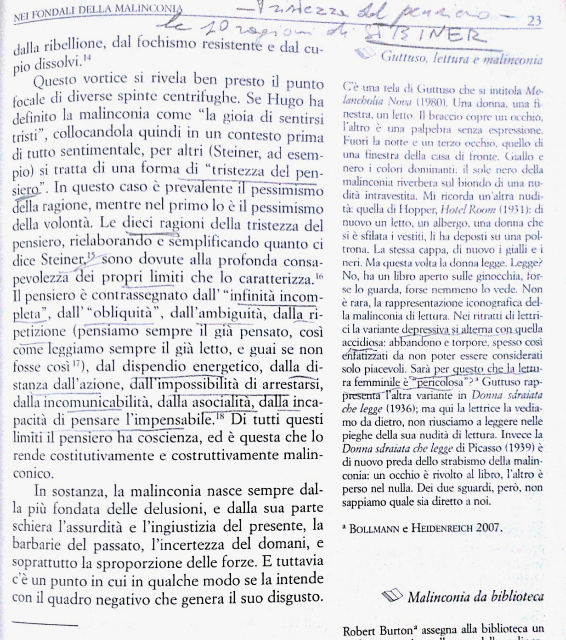
Mirabile poi l’apparato di note e la bibliografia: una miniera di spunti, suggerimenti di approfondimenti e digressioni, capaci di portarci in luoghi previsti e imprevedibili.
Alcune delle passioni e delle modalità delle quali parla Ferrieri:
malinconia (davvero protagonista e presente in tutta l’esperienza);
accidia;
letture notturne: insonnia, veglia e visione; sonno e sogno; le falene della lettura di Virgina Woolf; lettura della buonanotte e segreta lettura notturna.
E ancora: Lontananza, con la lettura dell’addio e la distanza (salutare vortice, appiglio contro una forte sofferenza che la lettura di immedesimazione produce nel lettore).
Lettura e la morte (con implicazioni di lutto e – ancora e sempre – malinconia).
Illeggibile.
Narcisismo.
Autocoscienza.
Lettura e velocità (e lentezza): «Afferma Peter Handke: “Sento la profonda esigenza non solo di leggere lentamente, ma di rallentare tutto me stesso quando leggo” È qui chiaramente espresso il rapporto di reciproco condizionamento che la lettura esercita sul mondo: essa è lenta in quanto esercita un’influenza rallentante anche fuori di sé.» [pag. 143].
Il silenzio della lettura (come modo di comunicare).
Nostalgia e ritorno.
Rilettura, ripetizione.
Nostalgia della comunità, letture condivise.
Lettura d’infanzia come nevicata.
Ricordare e dimenticare.
Mi perdonino Luca Ferrieri e tutti i lettori potenziali di questo libro bello e necessario, per il goffo tentativo di rappresentarne la ricchezza. La speranza è che si illumini la curiosità e l’interesse e l’identificazione nel lettore e nella comunità dei lettori (tanto cara all’autore) e che si moltiplichino i lettori che leggano questo libro.
Chiudo con un’altra breve citazione, ancora sulla malinconia – non prima di ricordare come le note a margine di autobiografia di lettore meriterebbero un altro approfondito post, vedremo – :
Alla malinconia del collezionista il lettore aggiunge quella del raccoglitore di scampoli e detriti, che in sé sembrano privi di valore e di senso; eppure sono disperatamente belli ed è a essi, più che all’opera madre, che lui si affeziona; il lettore gira le pagine come mercatini delle pulci, per piazzare (attraverso la citazione, l’appunto, il calco) e per trovare le sue gemme. Malinconico, nel senso più alto, è tutto ciò che circonda questa dimensione del lavoro di lettura, che è, perché è, un gioco di rapina: prima di raccoglierli i resti vanno strappati, sono spoglie. E chi lo compie, il lavoro sporco della lettura, si sente in colpa (possibile che di quel capolavoro io abbia serbato solo una frase, un’immagine? voleva questo? non voleva dire questo…) e insieme felice (ho messo in serbo il mio bottino, ogni volta che vorrò sarà mio). [pag. 34]
Lascia un commento