La biblioteca dei consigli. Introduzione ai servizi di orientamento alla lettura, Editrice Bibliografica, 2024
Il consiglio di lettura è una delle pratiche più sperimentate nelle relazioni fra i lettori e fra essi e l’universo del libro: siamo dentro quell’intreccio di possibilità di “scegliere quel che leggerò.”
Il consiglio è anche uno dei servizi importanti affidati alle biblioteche pubbliche. Questo intreccio fra compito istituzionale del servizio bibliotecario e pratica spontanea delle attività dei lettori, anche alla luce della diffusione sui social network di alcune forme specifiche di “consiglio”, rende il nuovo libro di Luca Ferrieri, – La biblioteca dei consigli. Introduzione ai servizi di orientamento alla lettura, Editrice Bibliografica, 2024 – particolarmente utile e importante non solo per i bibliotecari ma anche per i lettori più attenti alle modalità con cui si formano scelte di lettura e gusti. Senza dimenticare che attorno al consiglio di lettura, prendono forma anche alcune fra le più importanti esperienze di relazione fra persone, attorno e con la lettura.
Questa non è una recensione; è solo un consiglio, leggete questo libro!
LA FINE DEL CONSIGLIO E LA PROLIFERAZIONE DEI MICROCONSIGLI
Anche questa volta Ferrieri ci propone un’analisi ricchissima e piena di possibili sentieri di approfondimento; come sempre nei suoi lavori, d’altra parte, non manca di guardare il problema dritto negli occhi, senza nascondersi insidie, e controversie.
Tanto è vero che inizia con una rilettura di un frammento di Adorno nei Minima moralia, dedicato proprio alla “fine del consiglio”. È un crepuscolo direttamente collegato alla fine di altri tre capisaldi della società borghese: la conversazione, la distanza e il dono. [Il frammento di Adorno si intitola Posta nera, ed è l’aforisma n. 89.]
È importante notare però che questa fine del consiglio, scrive, “coincide con l’avvento di una miriade di microconsigli, pseudoconsigli, consigli per gli acquisti, istruzioni per l’uso, massime a buon mercato, suggerimenti non richiesti. La declinazione plurale non è indice di molteplicità ma di un parricidio in atto. La fine del consiglio avviene per mano dei consigli stessi o, meglio, la dinamica interna (entropica, per divisione e consunzione) è contemporanea e collegata a quella esterna (la fine del ruolo sociale del consiglio, la mattanza dei consiglieri). Nel momento in cui il consiglio, come stile di vita e di relazione, come corollario dell’amicizia e della prossimità, come esperienza ed experimentum mundi, come condivisione del sapere (ossia come forma di pre-lettura e di lettura) è tramontato, i suoi cloni caricaturali si sono moltiplicati all’infinito”. E ciò vale anche per la conversazione, la cui fine “si accompagna all’ipertrofia della chiacchiera”; e per il dono sostituito dall’industria del regalo, la caduta delle distanze accompagnata dal bisogno di solitudine. [p. 12]
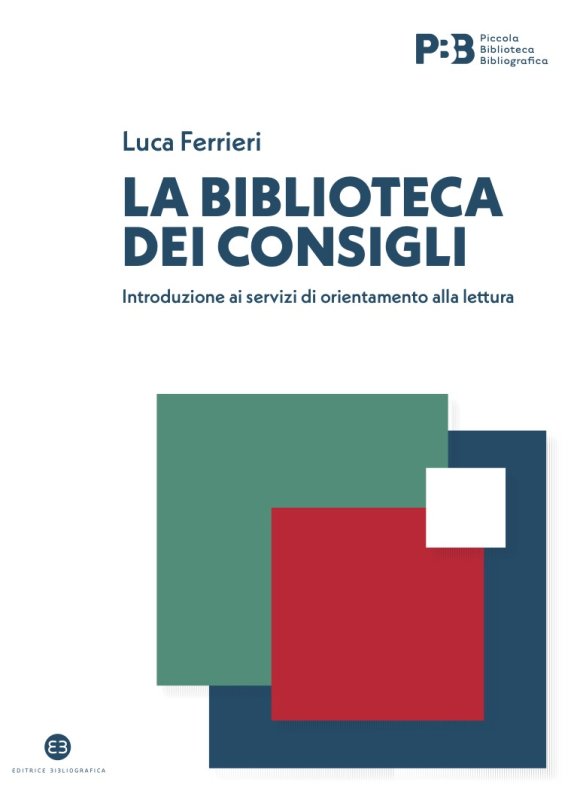
IL CONSIGLIO COME DIRITTO FONDANTE DELLA SOCIETÀ DELL’INFORMAZIONE
Ma è tutt’altro che un pianto sulla fine del consiglio. Si cerca invece di “imparare molto dalla sorte cui è andato incontro, che possiamo leggere anche come l’esito di un processo di secolarizzazione: la fine di un mondo in cui il sapere era posseduto da pochi e concesso, per grazia ricevuta, ai loro eredi o successori, insindacabilmente decisi. Lungi dal voler restaurare l’autentico, mitico Consiglio, – continua Ferrieri – capace di illuminare qualcuno solo al prezzo di gettare o lasciare nell’oscurità qualcun altro, cercheremo di mettere al centro i fenomeni di metamorfosi e di migrazione che oggi caratterizzano i consigli. Inseguiremo l’idea di un consiglio che non sia la calcolata elargizione del più saggio, ma un diritto fondante della società dell’informazione. Ci muoveremo quindi – continua – nell’universo della proliferazione selvaggia perché questo è l’habitat in cui ci troviamo, ma staremo in questo mondo per trasformarlo (dentro e contro è il motto icastico di questo posizionamento). Il consiglio si metterà alla ricerca del libro giusto, ma questo cammino non potrà avvenire senza un’idea di giustizia. Lo seguiremo nelle tappe evolutive, nelle sfide, negli ostacoli, ma anche nel semplice groviglio della vita pratica e della gestione bibliotecaria.”
IMMAGINAZIONE SPERIMENTALE
È un libro ricco di descrizioni delle pratiche oltre che di riflessioni e di inquadramenti teorici. È davvero indispensabile leggerlo per destreggiarsi ed esercitarsi in una “immaginazione sperimentale” alla quale “la fenomenologia del consiglio assegna la sua carica etica e la sua efficacia pratica. Lo vedremo più chiaramente – spiega l’autore – quando cercheremo di sovvertire l’idea convenzionale che il consiglio sia qualcosa che viaggia da un più a un meno, dal pieno al vuoto, che si pone su un podio e impone il prezzo di un’obbedienza e di una servitù sotto mentite spoglie. No, il consiglio è un abbraccio, non una lezione: e ci chiede, come prima cosa, di mettersi nella pelle (non sono nei panni) dell’altro, sia quando lo diamo, sia quando lo riceviamo” [p. 15].
LETTURA E CONSIGLIO
Concludo queste brevi note – che vorrebbero semplicemente essere un invito alla lettura del libro – sottolineando come Ferrieri insista sulla continuità fra mondo della lettura e mondo del consiglio, che trova nell’etica uno dei suoi fondamenti. Ebbene, è una continuità che possiamo mettere alla prova, seguendolo nel confronto/incrocio fra etica della lettura e etica del consiglio che ci propone.
Per etica della lettura, spiega Ferrieri, si intende:
-la visione della lettura come relazione, in particolare come relazione dialogica;
-la coscienza che l’esperienza della lettura è diretta all’incontro con l’altro, anzi, in termini lévinasiani, la lettura è ciò che rivela il volto d’altri;
-la coscienza del limite che innerva quest’esperienza, espressa anche nella differenza tra etica ed ermeneutica, perché l’etica sottolinea che la comprensione, in lettura, significa innanzitutto com-prendere, cioè ‘prendere con sé’, e quindi mette in guardia verso la possibile deriva ermeneutica della “semiosi illimitata”;
-la sottolineatura della responsabilità interna all’atto, che pesa sulle spalle di tutti gli attori, ma in particolare su quelle del lettore (e qui non c’è una gran differenza tra un’etica della responsabilità e un’etica consequenzialistica, questo è uno dei miracoli della lettura);
-la descrizione e l’analisi degli effetti e dei problemi che si verificano quando le diverse passioni si applicano e si esprimono attraverso la lettura (in questo caso la declinazione etica è di tipo spinoziano, è un’analitica delle passioni). [pp.77-78].
[Aggiungo che queste pagine sono anche un’ottima occasione per leggere una illuminante sintesi della differenza, che non dovremmo dimenticare mai, fra l’approccio etico alla lettura e l’approccio morale e moralistico: quest’ultimo ha portato solo danni alla lettura “con la sua attività sottilmente censoria e con il segregazionismo delle ‘cattive letture’, classificate come tali non in base alla qualità ma a presunti effetti sul lettore”. Sempre sul tema, Ferrieri, sul modello che Pino Menzio* ha applicato alla scrittura, ci ricorda l’efficacia del distinguere fra un’etica ‘interna’ alla lettura e un’etica ‘esterna’. La prima scaturisce dall’atto stesso di lettura, è “autonoma e autofinalizzata, fondata sulla differenza, l’alterità e l’ospitalità”; la seconda, invece, “è imposta dall’esterno, da preoccupazioni estranee al testo, da principi morali o moraleggianti preesistenti, e facilmente sconfina nell’ideologia e nel dogmatismo”.]
L’etica del consiglio, dice Ferrieri, è invece più semplice, e cita la sintesi di Emily Lawrence*, fondata su tre punti:
-Il rispetto per l’autonomia, l’autodeterminazione e la capacità di scelta del lettore a cui si rivolge il consiglio (ciò implica il rifiuto del paternalismo e delle ingerenze nella libertà personale e intellettuale);
-l’egualitarismo che si esplica nell’uguale considerazione e trattamento di ogni lettore;
-la convinzione del valore della lettura, anche se, ‘non vi è accordo sullo sua natura’, come dice Lawrence; ovvero non vi è accordo sul fatto che essa abbia un valore ‘intrinseco’ o ‘estrinseco’, che riceva valore da se stessa o da un’altra fonte.
Lascio alla lettrice e al lettore che decida di leggere La biblioteca dei consigli, il piacere e l’interesse degli intrecci che propone Ferrieri in questa parte e nel resto del libro, che, va ribadito, affronta una questione che riguarda tutti coloro che si occupano di lettura, ben oltre i limiti della professione bibliotecaria.
Prima di chiudere, confesso di essere entrato in questo libro (nel quale ancora stazionerò a lungo, credo) passando non dalle primissime pagine, ma dalle note del primo capitolo e soprattutto da pagina 21, dove il paragrafo La quintuplice radice del principio di consiglio, ci accompagna nelle “cinque principali caratteristiche della sua natura” e in alcune delle loro diramazioni. Ci torneremo: per ora cito solo queste caratteristiche: la natura del consiglio è 1) disinteressata 2) ipotetica, 3) associativa, 4) serendipica, 5) asintotica [p. 21 e ss.]
Trascrivo qui sotto la quarta di copertina, e i titoli dei capitoli per agevolare la comprensione della portata del lavoro.
I capitoli:
1 Fenomenologia del consiglio
2 Le sfide del consiglio di lettura
3 La biblioteca come luogo di consiglio
4 Intelligenza collettiva, connettiva, artificiale
La quarta di copertina:
“I servizi di consiglio di lettura sono un esempio dei modi in cui le biblioteche affrontano l’attuale fase di transizione attraverso la metamorfosi dei vecchi servizi e/o la nascita di nuovi. Questo saggio esamina il variegato territorio dei consigli di lettura partendo dalla loro esistenza nelle relazioni tra le persone, esaminando poi la loro storia dentro e fuori la biblioteca, per concentrarsi infine sulla dimensione di un possibile servizio da introdurre anche nelle librerie, tra e con i gruppi di lettura. Nel finale viene affrontato inoltre il tema delle innovazioni, delle potenzialità e delle incertezze legate agli sviluppi del digitale e delle forme di intelligenza artificiale, che sono sempre più presenti nella vita della biblioteca e nei processi di formazione ed erogazione dei consigli di lettura.”
Immagine in apertura: Maurice Prendergast, In biblioteca, 1906 Wikiart
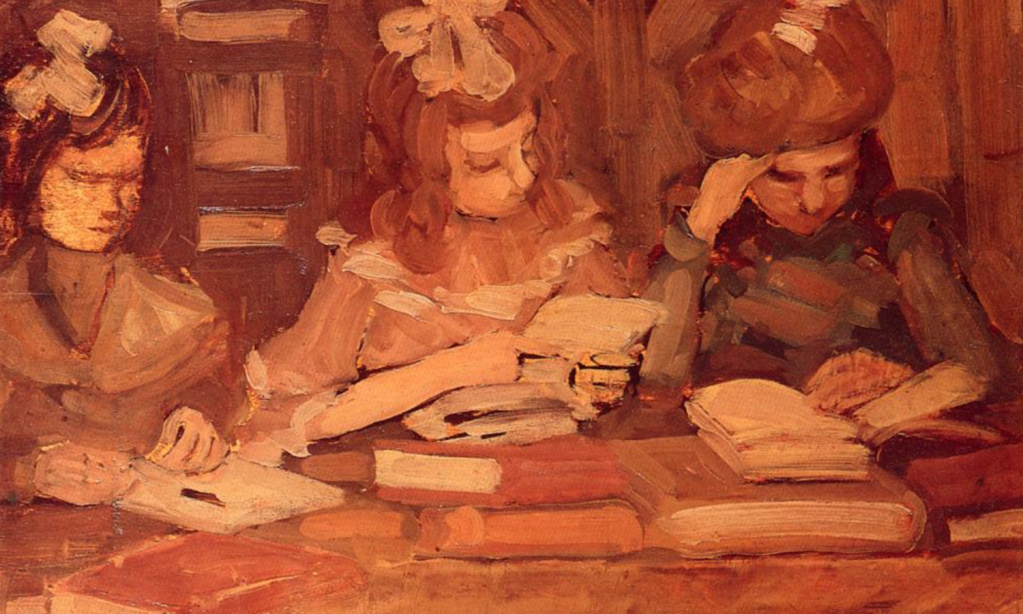
Lascia un commento